La giraffa è il mammifero terrestre più alto del pianeta.
Originaria dell’Africa subsahariana, è facilmente riconoscibile per il lungo collo, le zampe sottili e il caratteristico mantello maculato.
Appartiene alla famiglia Giraffidae, che comprende solo un altro membro vivente: l’okapi (Okapia johnstoni).
La giraffa in breve
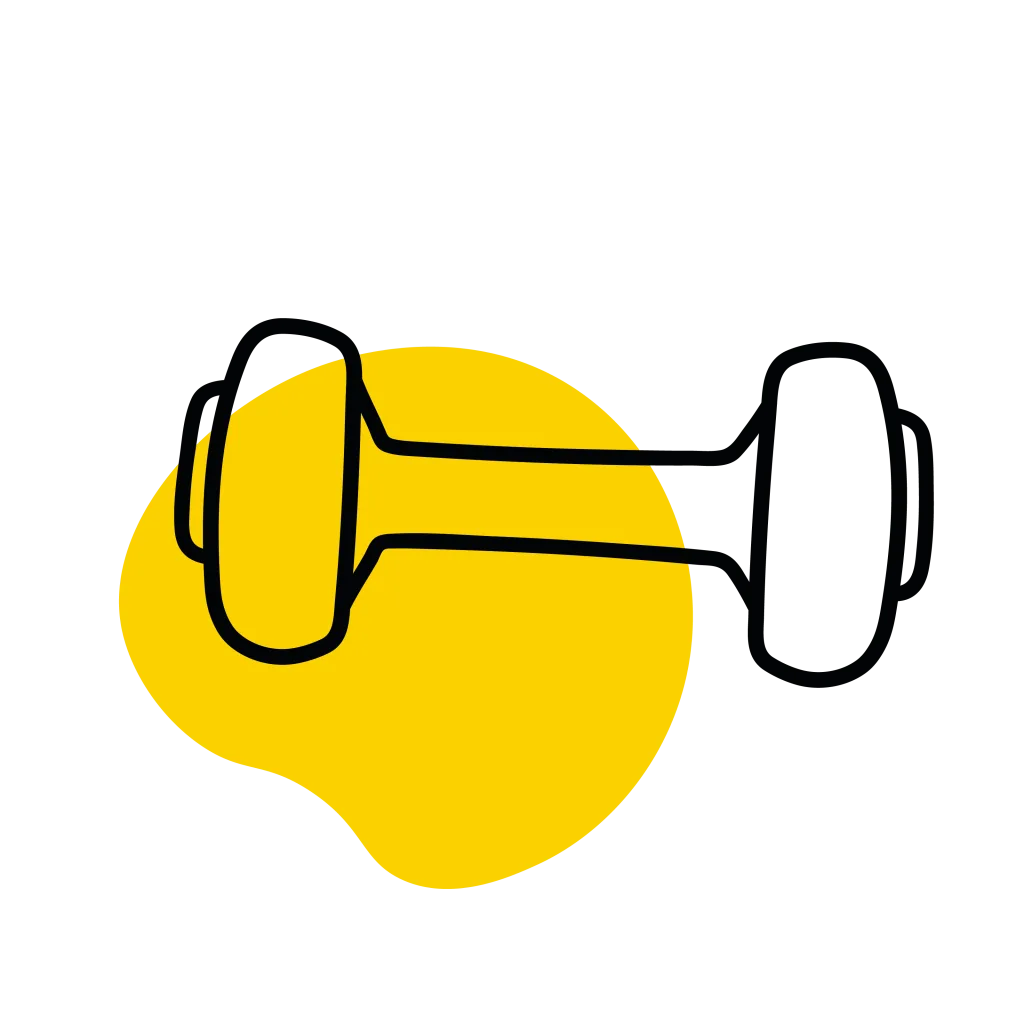
800 kg Femmine
1.200 kg Maschi

5 metri Femmine
6 metri Maschi
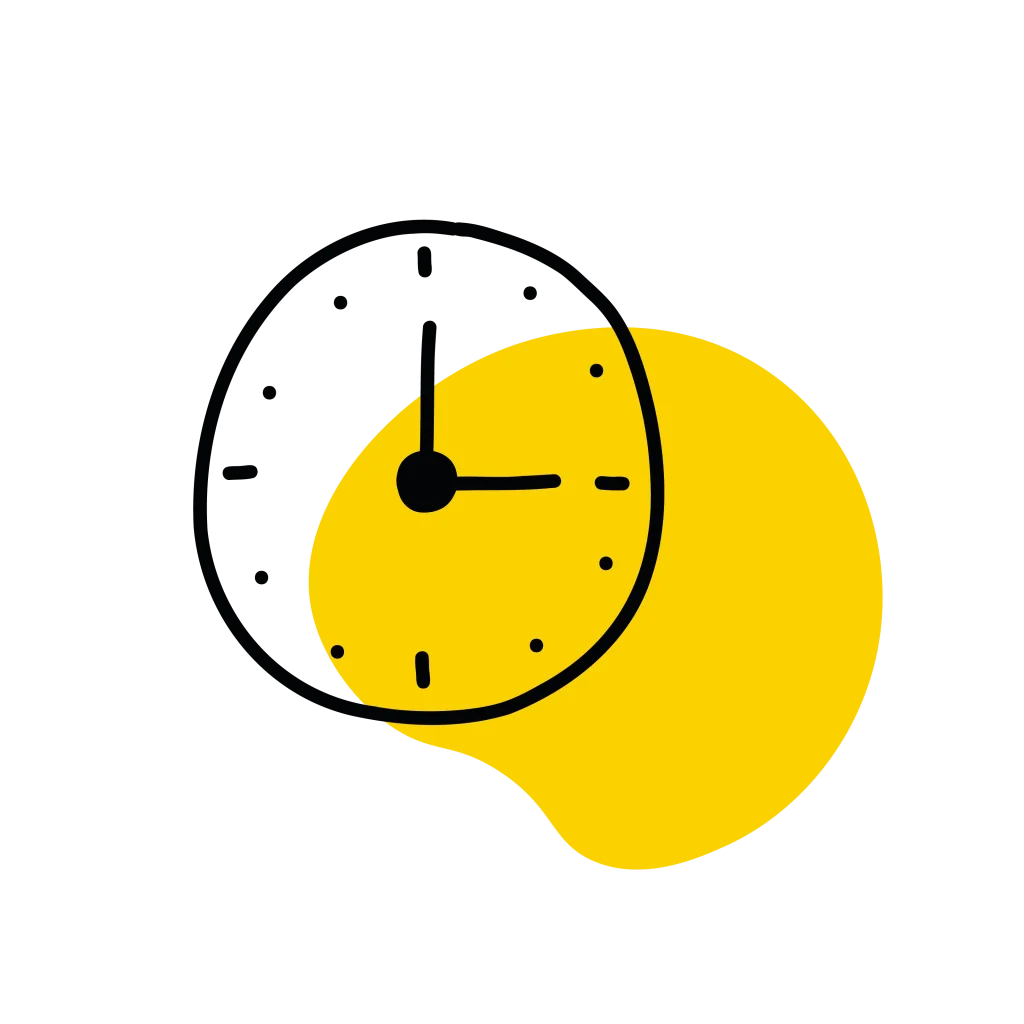
25 anni

NON territoriale
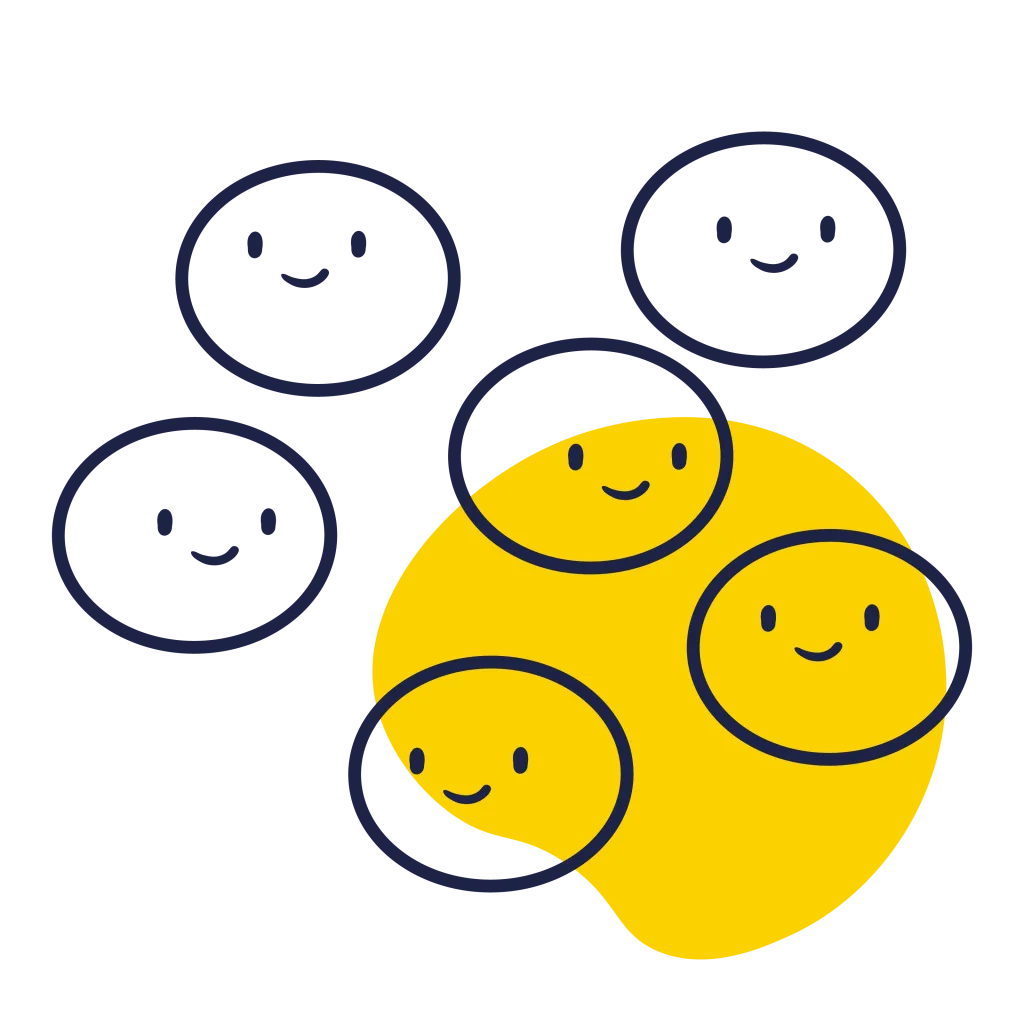
Gruppo aperto
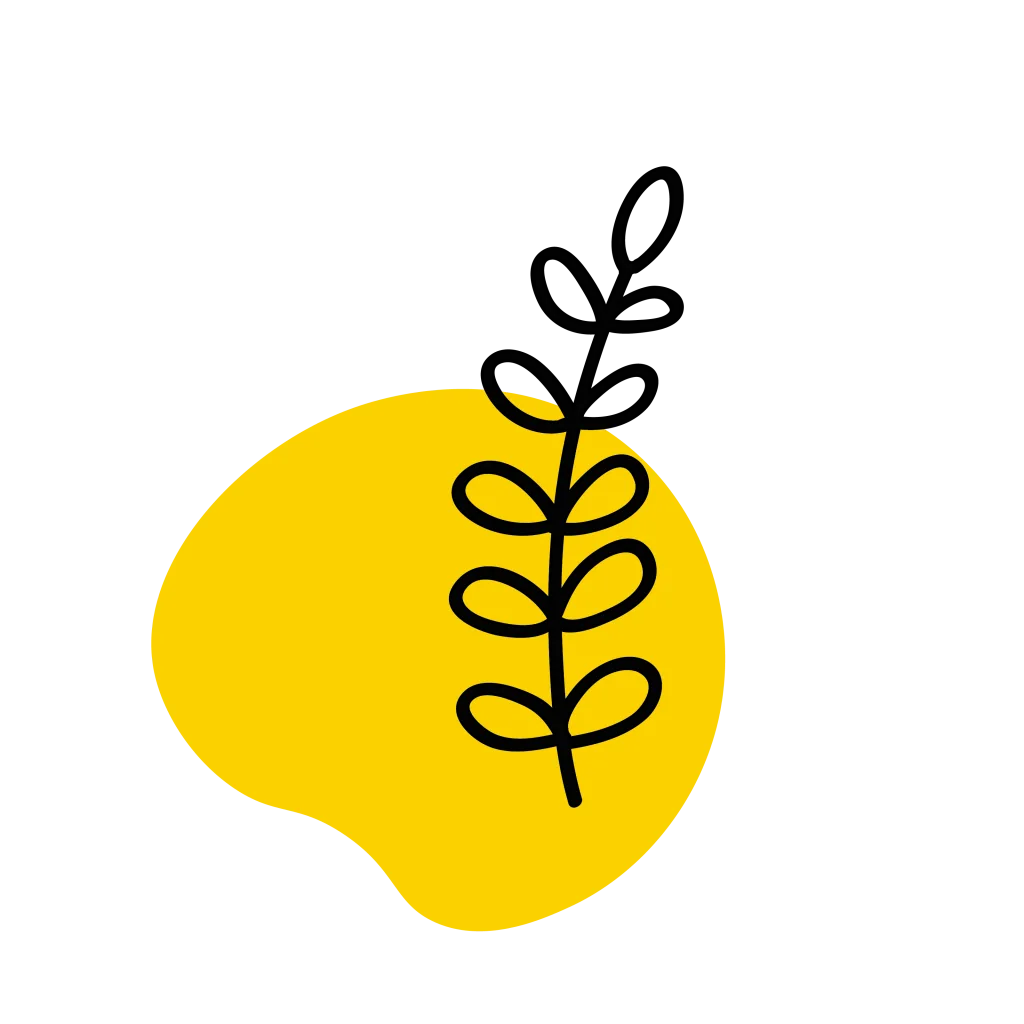
Erbivoro – Foglie
Etimologia del nome
Il nome scientifico Giraffa camelopardalis è un riferimento storico alla sua apparenza.
“Camelopardalis” deriva dal latino e significa “cammello-leopardo”, una descrizione adottata dagli antichi romani per via del lungo collo (come un cammello) e del mantello maculato (simile a un leopardo).
Il nome comune giraffa deriva invece dall’arabo “zarāfa“, il cui significato possibile può essere “colei che cammina velocemente” oppure “elegante nel passo”.
Classificazione e sottospecie
Tradizionalmente si riconoscevano nove sottospecie di giraffa, ma studi genetici recenti (Fennessy et al., 2016) suggeriscono l’esistenza di soltanto quattro specie distinte:
- Giraffa camelopardalis (giraffa settentrionale)
- Giraffa giraffa (giraffa meridionale)
- Giraffa tippelskirchi (giraffa Masai)
- Giraffa reticulata (giraffa reticolata)
Le differenze si notano nel disegno del mantello, nella distribuzione geografica e nei dati genetici.
Anatomia e fisiologia
Collo
Nonostante la lunghezza (oltre 2 metri), il collo della giraffa ha lo stesso numero di vertebre cervicali degli esseri umani e di (quasi) tutti i mammiferi: sette.
Spalmate però su 2 metri di lunghezza, le vertebre della giraffa sono molto grandi, raggiungendo anche i 30 cm.
Tutti i mammiferi hanno 7 vertebre cervicali?
Quanto sono grandi le vertebre cervicali di un essere umano?
Se abbiamo visto che le vertebre cervicali di una giraffa sono lunghe fino a 30 cm, negli esseri umani le sette vertebre cervicali (C1–C7) sono di circa 2,5 cm.
Quali sono gli animali con più vertebre cervicali?
I serpenti possono avere più di 300 vertebre totali, e quelle anteriori ovviamente non è poi così facile distinguerle in cervicali, toraciche, ecc.
Negli uccelli la valutazione è molto più semplice, e possiamo dire che il cigno detiene il record con 25 vertebre cervicali, seguito da fenicottero e airone con 22 e lo struzzo con 19.
Gli uccelli meno dotati sono invece i pappagalli con 10-12 vertebre e i passeriformi con 14.
Il collo della giraffa è uno degli adattamenti evolutivi più iconici e discussi della zoologia. Perché la giraffa ha sviluppato un collo così lungo? Gli scienziati hanno proposto diverse teorie evolutive, spesso complementari tra loro.
Le principali teorie sull'evoluzione del collo della giraffa
Teoria della competizione alimentare (Darwin)
Secondo Charles Darwin, la giraffa ha sviluppato un collo lungo per raggiungere le foglie più alte degli alberi, evitando la competizione con altri erbivori.
Le giraffe possono infatti cibarsi di foglie alte (ad esempio di acacia) in periodi di siccità, quando la vegetazione bassa era esaurita.
Il fatto che nessun altro animale (ad eccezione talvolta degli elefanti) riesca ad arrivare così in alto, avrebbe favorito la sopravvivenza degli individui con il collo più lungo.
Ed ecco che la selezione naturale ha fatto sì che potessero andare avanti i geni del collo lungo.
Teoria della vigilanza e della predazione
Un collo lungo migliora la capacità di avvistare predatori da lontano, per cui le giraffe più alte individuano prima i pericoli.
Da qui … le giraffe vengono considerate le sentinelle delle savane, e sfruttate da molte altre specie nell’individuare il pericolo imminente.
Teoria multifattoriale
Secondo i più recenti studi genetici, il collo lungo è il risultato combinato di più pressioni selettive: alimentazione, selezione sessuale e predazione.
Questa è l’ipotesi oggi più accettata dalla comunità scientifica.
Il collo avrebbe garantito vantaggi alimentari, vantaggi competitivi tra i maschi (necking) e vantaggi di sorveglianza, agendo tutti insieme.
Perché l’okapi ha il collo lungo?
L’okapi (Okapia johnstoni), cugino stretto della giraffa, ha un collo insolitamente lungo per un animale della foresta, anche se ovviamente non così estremo come quello della giraffa.
Okapi e giraffa condividono un antenato comune vissuto circa 11–12 milioni di anni fa, ed entrambi appartengono alla famiglia Giraffidae.
Questo antenato probabilmente aveva già un collo parzialmente allungato, e l’okapi ha conservato questa caratteristica in forma moderata.
L’okapi vive nelle foreste pluviali del Congo, dove non c’è bisogno di raggiungere rami alti. La vegetazione però è molto fitta: tra arbusti, liane, fogliame spesso e rami ravvicinati, le foreste pluviali del bacino del Congo sono tra le più fitte e impenetrabili al mondo.
Il collo lungo consente sì di brucare foglie a diverse altezze, ma è utile soprattutto per vedere oltre la parte più fitta e bassa della vegetazione, quindi per muoversi agilmente tra rami e liane.
Inoltre, avere un collo lungo aiuta l’okapi a rilevare visivamente e olfattivamente l’ambiente sopra la vegetazione bassa.
Cuore e sistema circolatorio
Il cuore pesa fino a 11 kg e genera una pressione sanguigna doppia rispetto a quella umana (260/160 mmHg).
Il sistema circolatorio è dotato di valvole nelle vene giugulari e di arterie ispessite per evitare danni quando la giraffa abbassa la testa (ad esempio per bere).
Lingua
Lunga fino a 50 cm, la lingua della giraffa è è prensile, flessibile e muscolosa. Grazie alla lingua così “abile”, la giraffa riesce ad afferrare e strappare le foglie dagli alberi, facendo una sorta di slalom attorno ai rami per evitare le spine.
La parte superiore è scura, solitamente di colore blu o viola, mentre la base è rosata.
L’elevata concentrazione di melanina sembra serva a proteggere la lingua dai danni causati dai raggi UV durante le lunghe ore di alimentazione sotto il sole.
Come si proteggono le giraffe dalle spine delle acacie ?
Abbiamo visto che la lingua è prensile e molto agile, tanto da riuscire a destreggiarsi tra le spine per prendere le foglie.
Ma se la giraffa è tanto ghiotta di foglie di acacia, la lingua non può essere l’unica soluzione che Madre Natura le ha donato per proteggersi dalle spine.
Le labbra sono spesse, in modo da fare una sorta di cuscinetto in entrata.
E il palato è duro, le gengive callose, per cui può comprimere e masticare le foglie e le spine annesse senza farsi (troppo) male.
Le narici sono verticali (piatte) e hanno una forte muscolatura che permette alla giraffa di chiuderle completamente.
Questo adattamento anatomico consente alla spilungona non solo di letteralmente tapparsi il naso in caso di sabbia o vento, ma anche quanto infila il muso in rami particolarmente spinosi, per evitare piercing spiacevoli.
Inoltre le ciglia molto lunghe fungono un po’ da antenna, captando come le vibrisse dei gatti gli oggetti potenzialmente troppo vicini e facendo automaticamente chiudere gli occhi.
In questo modo proteggono gli occhi dalle spine, ma anche fungono da barriera contro polvere, sabbia, semi e insetti.
Apparato digerente
La giraffa è un ruminante, il che significa che possiede uno stomaco suddiviso in quattro compartimenti: rumen, reticolo, omaso e abomaso.
Questo sistema consente alla giraffa di ingerire il cibo per poi rigurgitarlo e rimasticarlo per facilitare la digestione delle fibre vegetali.
In media una giraffa adulta mangia fino a 40-45 kg di vegetali al giorno e, grazie al suo sistema ruminante, ha un’efficienza digestiva di circa 85%.
Questo significa che trasforma solo il 15% di quello che mangia in cacca (dei cilindretti grandi più o meno quanto un’unghia, compressi come un pellet), mentre l’85% viene digerito e assimilato dall’organismo (cioè trasformato in nutrienti utili come zuccheri, grassi).
Ha 32 denti (come l’essere umano), tra cui importanti sono i molari, per masticare il cibo.
Importante è anche l’assenza degli incisivi superiori: le nostre giraffe sono infatti sdentate davanti, dove invece hanno una gengiva dura e rinforzata, contro cui gli incisivi inferiori premono per strappare le foglie.
Andatura
Cammina in ambio, muovendo cioè contemporaneamente le gambe dello stesso lato.
Questo vuol dire che quando cammina (o corre) la giraffa sposta le zampe davanti e dietro destra, e poi le zampe davanti e dietro sinistra. Insomma, barcolla un po’.
Questa andatura un po’ ciucca è il modo migliore per coordinare zampe lunghe, infatti anche cammelli e dromedari camminano in ambio.
Ma è quando corre che la giraffa dà il meglio di sé.
Considerato un animale elegante, se la vedete correre potreste ricredervi.
Ma nonostante la corsa buffa e ridicola, con quelle stanghe di zampe che si ritrova, la giraffa abbandona l’ambio e in galoppo può raggiungere quasi i 60 km/h.
Ossiconi
Quelle due antennine pelose che spuntano in testa alla giraffa no, non sono corna.
Le giraffe non hanno corna.
Hanno ossiconi.
Gli ossiconi sono ossa ricoperte di pelle e peli. Sono presenti alla nascita come cartilagine e si ossificano nel tempo.
Perché alcune giraffe hanno la fronte bitorzoluta ?
Con il passare degli anni gli ossiconi e la fronte possono diventare bitorzolute, soprattutto nei maschi.
Questo effetto è dovuto alla crescita di escrescenze ossee irregolari che si formano nel tempo.
Ma perché succede soprattutto ai maschi?
La causa principale è il necking, cioè i combattimenti tra maschi per il dominio e l’accesso alle femmine.
A forza di darsele a suon di testate, i colpi ripetuti provocano microtraumi alle ossa craniche.
E in risposta il corpo deposita nuovo tessuto osseo per rafforzare le zone sollecitate, e quindi abbiamo un ispessimento e la formazione di questi bernoccoloni.

Che differenza c'è tra corna e ossiconi ?
Gli ossiconi sono vere e proprie ossa ricoperte da pelle e peli.
Come se fosse una qualsiasi protuberanza del corpo, con la differenza che gli ossiconi hanno pochissima sensibilità e nascono come cartilagine, che si ossifica nel tempo.
Le corna invece hanno il nucleo osseo, come gli ossiconi, ma attorno sono ricoperte di cheratina.
Nell’immagine seguente si nota non solo l’assenza dei denti incisivi superiori, ma anche come gli ossiconi facciano parte del teschio, essendo un tutt’uno con l’ossatura del cranio.
La mucca, invece, ha le corna ben visibili. Questo perché la pelle che ricopre gli ossiconi non c’è più, mentre rimane la guaina protettiva in cheratina.
Come distinguere i maschi dalle femmine nelle giraffe?
- Taglia: maschi più grandi e robusti
- Ossiconi: più spessi e spelacchiati nei maschi, più sottili e pelosi nelle femmine
- Colorazione: i maschi adulti tendono a scurirsi
- Comportamento: i maschi possono essere solitari, le femmine più spesso vivono in gruppi con i cuccioli e i giovani
Che struttura sociale hanno le giraffe?
Le giraffe vivono in gruppi aperti, in cui gli individui, sia maschi che femmine, entrano ed escono liberamente.
Insomma, alle giraffe non gliene frega niente. Vogliono stare da sole? stanno da sole. Vogliono compagnia? si aggregano.
Sono gli animali più socialmente sereni dell’universo.
Le femmine tendono a formare legami più stabili, spesso famigliari, mentre i maschi adulti diventano più solitari con l’età e possono percorrere anche grandi distanze alla ricerca di femmine in estro. Ma quando decidono di formare gruppi, possono farli piccoli o arrivare fino a 30 individui.
Come si regolano per la riproduzione? Il necking
Partiamo dalle basi: non tutti i maschi hanno il diritto di riprodursi con le femmine in estro, ma solo i dominanti.
E come si determina un maschio dominante? A suon di mazzate di collo.
I maschi combattono tra loro dandosi craniate (sfruttando gli ossiconi) e colpi con il collo.
Col tempo, i maschi sviluppano ossificazioni craniche più pronunciate, che li rendono più resistenti nei duelli, per cui più sono esperti e più hanno possibilità di vincere.
Nella maggior parte dei casi, il necking rimane un rituale non pericoloso, in cui i due maschi si scontrano a colpi e testate in cui il maschio più debole cede prima che il duello si intensifichi troppo.
A volte però lo scontro può diventare violento e i colpi possono causare fratture craniche, dislocazioni cervicali e contusioni interne.
Il colpo potrebbe essere così forte da far crollare a terra l’avversario e, in rari casi, l’animale può morire per trauma cranico.
Il necking è il principale responsabile della “pelata” che i maschi si ritrovano in cima agli ossiconi, che rimangono invece pelosi nelle femmine.
Dopo che il maschio ha stabilito la sua dominanza, ha il diritto di accoppiarsi con le femmine in estro.
I maschi sono in grado di valutare la fertilità delle femmine attraverso il flehmen, cioè l’atto di annusare l’urina della femmina sollevando il labbro superiore per analizzare i feromoni tramite l’organo di Jacobson (o organo vomeronasale).
Trovata una femmina in estro, il maschio dominante inizia a seguirla da vicino, camminandole in parallelo, tentando uno sfioramento di tanto in tanto.
Se lei non lo scaccia e dà il consenso, allora ci può essere l’accoppiamento.
E dopo? Sigaretta e via?
Praticamente sì: il maschio se ne va, alla ricerca di altre femmine ricettive, lasciando la donzella da sola.
La nascita
Sono infatti esclusivamente le femmine ad occuparsi della cura dei piccoli.
Dopo una gestazione di circa 15 mesi, nasce un solo cucciolo.
L’affaccio al mondo del giraffino non si può dire sia dei migliori: cade infatti al suolo da un’altezza di circa 2 metri.
L’atterraggio è brusco, ma aiuta a rompere il sacco amniotico e soprattutto stimola la respirazione e innesca i primi riflessi vitali.
Il neonato pesa 50-70 chili e misura circa 1,80 metri, quindi è già più alto di un uomo adulto medio!
Entro mezz’ora dalla nascita (dategli il tempo di riprendersi, insomma, è una nascita un po’ traumatica dopo tutto), il cucciolo prova ad alzarsi, e con molte cadute iniziali dopo 1 ora che è al mondo già cammina e inizia a cercare il latte.
Le madri formano spesso “asili nido” o “creches”, dove una femmina sorveglia i piccoli mentre le altre si nutrono. Questa cooperazione migliora la sopravvivenza dei cuccioli, offrendo protezione contro i predatori.
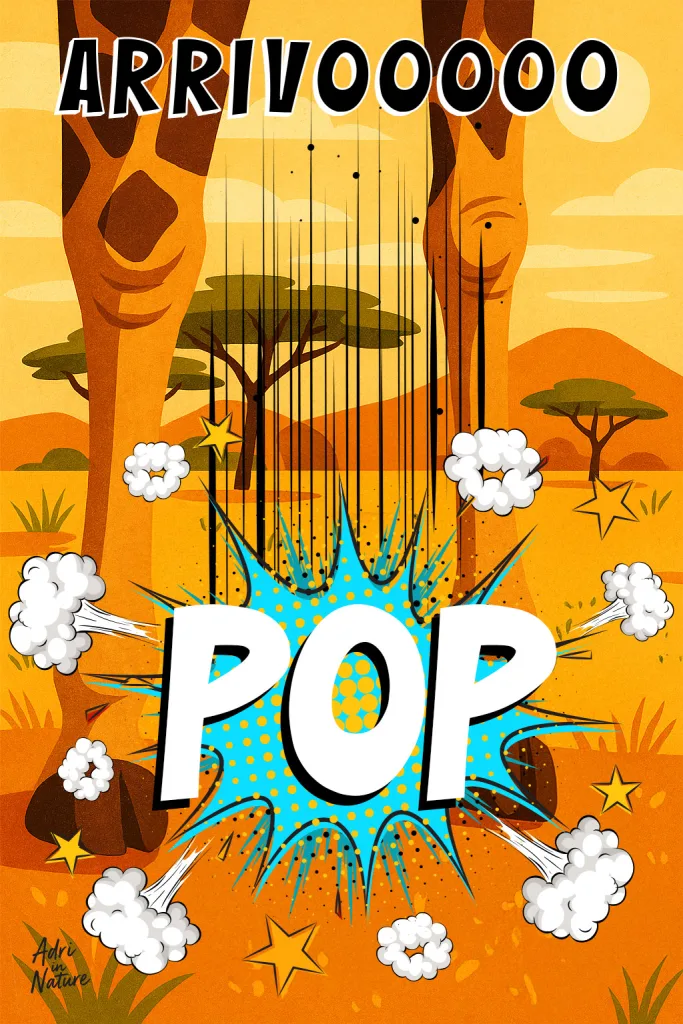
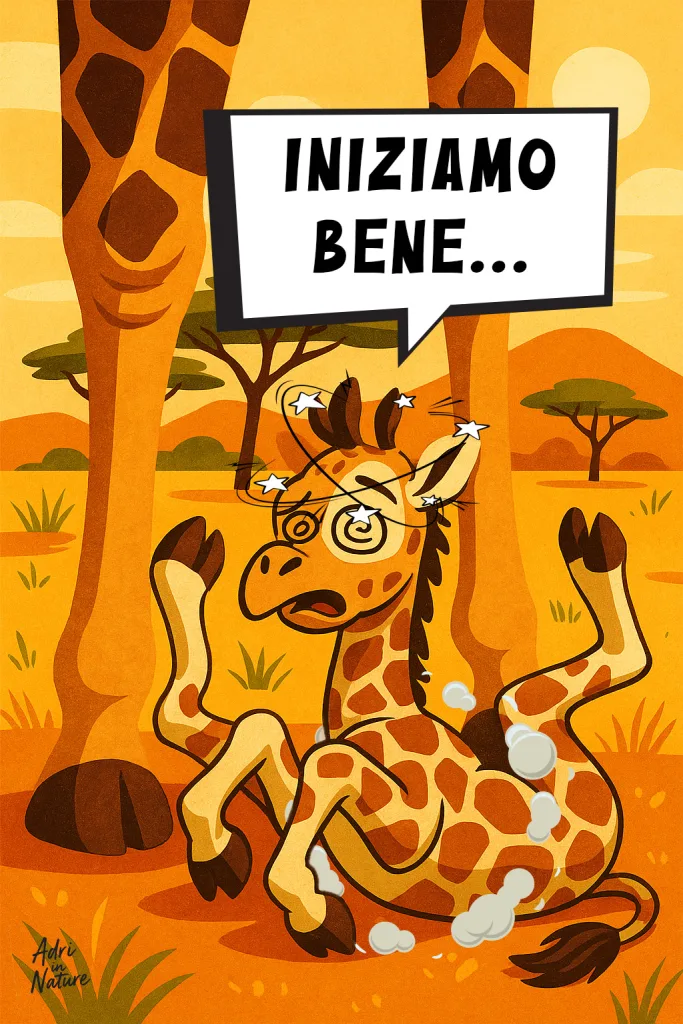
Come comunicano le giraffe?
Se la domanda che ci ha assillato nella nostra infanzia è stata “Il coccodrillo come fa?” anche con la giraffa però non si scherza…
Dico, qualcuno ha mai sentito un vocalizzo della giraffa?
Le giraffe producono infrasuoni (cioè suoni al di sotto della soglia uditiva umana di circa 20 Hz) per comunicare su lunghe distanze.
Questi suoni non li sentiamo, ma sono utilizzati da molti animali perché viaggiano efficacemente nell’aria e sono in grado di percorrere lunghe distanze.
Ma cosa si intende per “lunghe distanze”?
Anche se non ci sono misurazioni esatte per le giraffe come per gli elefanti, si stima che i loro infrasuoni possano viaggiare tra i 2 e i 5 km, e forse oltre, in condizioni favorevoli (assenza di vento, poco rumore ambientale).
Giusto per fare un paragone, se un essere umano si mettesse a urlare, in condizioni di silenzio totale e senza ostacoli, può essere udito a circa 1 km, massimo 2 km.
Ma ci sono anche altri versi che in rari casi possono essere documentati: ad esempio sbuffi, ringhi, simil-muggiti specialmente tra madri e cuccioli o nei confronti di minacce.
Ma le giraffe comunicano soprattutto in modo non verbale, utilizzando segnali visivi e posture.
Ad esempio l’inclinazione del collo e della testa può indicare dominanza o sottomissione.
Il contatto visivo prolungato o l’imitazione dei movimenti è spesso segnale di attenzione sociale.
Simbiosi e interazioni con altri animali della savana
Le giraffe sono parte attiva dell’ecosistema e si relazionano con molti altri animali in rapporti di simbiosi, commensalismo o semplice coesistenza ecologica.
Le bufaghe
La relazione tra grandi mammiferi e questi piccoli uccelli sono un classico esempio di mutualismo: due esseri viventi ottengono entrambi benefici dalla relazione che li lega.
Le bufaghe si posano infatti sul corpo delle giraffe e si nutrono di zecche, larve e parassiti presenti nella pelle.
In cambio del facile pasto, offrono un servizio di “pulizia” liberando il grande mammifero dai parassiti, ma anche di allarme: emettono infatti un verso acuto se percepiscono pericoli, come predatori in arrivo.
Attenzione però! Alcuni studi recenti suggeriscono che le bufaghe possono anche peggiorare piccole ferite per nutrirsi del sangue, quindi in certi casi il rapporto potrebbe oscillare verso il parassitismo (cioè il rapporto tra due esseri viventi in cui uno ha un beneficio, a discapito dell’altro).
Zebre e gnu
È abbastanza comune vedere insieme giraffe, zebre e gnu.
Condividendo habitat e territori, zebre e gnu preferiscono stare vicino a chi è in grado di individuare più facilmente i predatori: grazie alla loro altezza, le giraffe spesso individuano il pericolo da lontano e, semplicemente alzando la testa e fissando un punto, mettono in allarme l’intera comunità.























