Antilope impala
- Nome scientifico: Aepyceros melampus
- Nome inglese: Impala
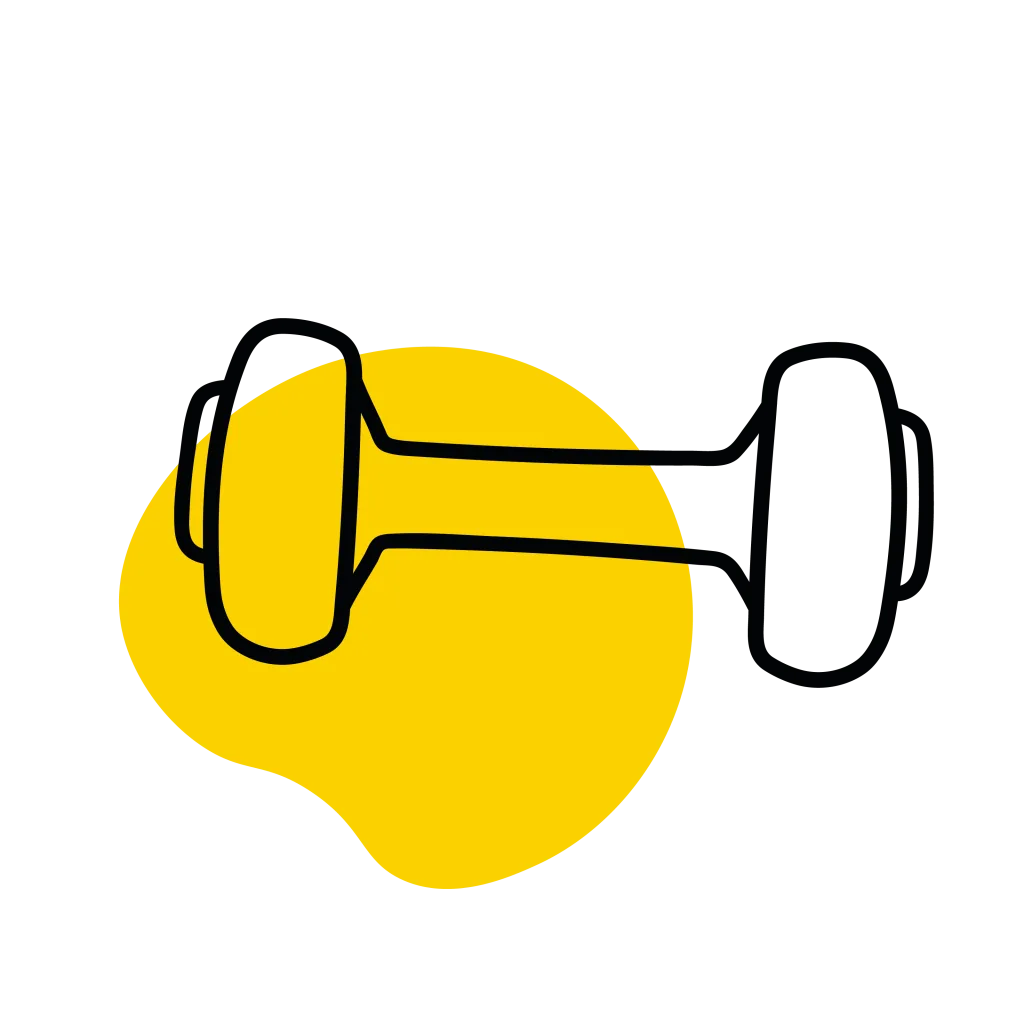
50 kg Femmine
70 kg Maschi
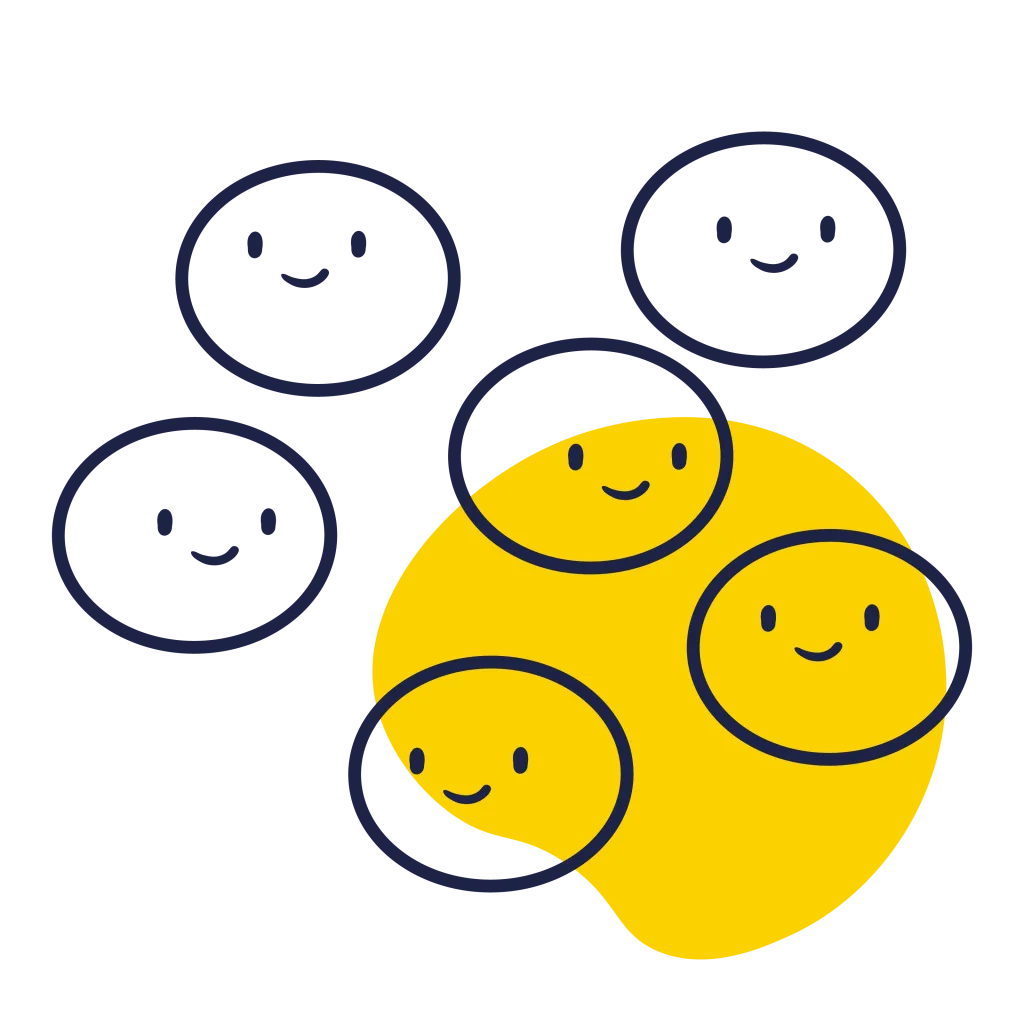
Gruppi di femmine
Bachelors group
Territoriale
Erbivoro
Browser – Grazer
Dimorfismo sessuale
L’impala presenta un chiaro dimorfismo sessuale che rende facilmente riconoscibile il maschio dalla femmina durante i nostri safari.
Ok, i maschi sono più grandi delle femmine, ma è molto più semplice: i maschi hanno le corna, dalla caratteristica forma a lira, le femmine no.
Fine.
Cosa sono le macchie nere che si vedono lungo le zampe?
Quelle macchie nere che si vedono soprattutto sulla parte posteriore delle zampe sono ghiandole odorifere specializzate, chiamate metatarsal glands (ghiandole metatarsali).
A cosa servono?
-
Comunicazione chimica
Rilasciano feromoni che lasciano una traccia olfattiva sul terreno o sulla vegetazione. Questo li aiuta a segnare il territorio o a ritrovare i percorsi seguiti da altri membri del branco. -
Coesione sociale
Permette ai membri del gruppo di riconoscersi tramite l’odore, soprattutto quando si muovono in habitat fitti o durante le fughe dai predatori. -
Segnalazione durante la fuga
Oltre al segnale visivo (la macchia bianca sulla groppa), il tracciamento olfattivo potrebbe aiutare i piccoli a seguire gli adulti durante una fuga caotica.
Dieta
L’Impala è estremamente adattabile:
- generalmente è un browser, cioè mangia foglie, germogli, frutti, semi
- durante la stagione delle piogge diventa un grazer, cioè bruca erba fresca
Questa flessibilità alimentare lo rende una delle antilopi più diffuse nell’Africa sub-sahariana.
Quindi diciamo che la sua dieta estremamente varia e opportunista fa sì che l’Impala sia nella dieta di numerosissimi carnivori.
Fossi in lui, cambierei nutrizionista.
Il salto e lo stotting degli Impala
Gli Impala sono saltatori eccezionali: possono saltare fino a 3 metri di altezza e coprire 10 metri in lunghezza in un unico balzo.
Questo serve sia per sfuggire ai predatori sia per superare ostacoli naturali come cespugli e arbusti.
Gli Impala sono noti per le loro fughe saltellate.
In più praticano quello che viene definito lo “stotting“.
Lo stotting è principalmente un comportamento anti-predatorio: quando sono sotto stress per potenziali minacce, o durante un attacco, li vediamo saltare verticalmente con le zampe rigide, la schiena arcuata e spesso sollevano anche la coda mostrando la macchia bianca.
Ma perché hanno questo buffo comportamento?
Praticamente stanno facendo una dimostrazione di quanto sono in forma.
È come se stessero dicendo ai predatori (se durante un attacco) o potenziali predatori (se si sentono minacciati) “Guarda come sono atletico. Se decidi di inseguire me, sprecherai energie”.
Un’altra funzione è quella di confondere il predatore, saltando in alto e cambiando traiettoria non appena toccano terra.

La differenza tra stotting degli Impala e pronking degli Springbok
Chi è stato in Namibia sicuramente si ricorderà degli Springbok, che, così come gli Impala lo sono per il Sudafrica, sono le antilopi più comuni della Namibia.
Anche gli Springbok, come gli Impala, hanno questa caratteristica dimostrazione di fitness, chiamata “pronking“.
Ma stotting e pronking sono la stessa cosa?
A prima vista sì (se vogliamo semplificare, le antilopi saltano in alto), ma non è esattamente così.
Habitat
L’Impala predilige habitat con un po’ di copertura vegetativa, ma con anche zone aperte, come boscaglie rade, savane alberate e zone con acque permanenti.
Non frequenta né il deserto né le praterie aperte prive di copertura.
Si trova tipicamente nei pressi di fonti d’acqua, essendo fortemente dipendente dall’acqua per la sopravvivenza.
Perché gli Impala hanno la caratteristca M nera sul culetto?
E’ quello che viene definito “follow me signal”.
Abbiamo detto che l’Impala vive in ambienti misti (boscaglia e zone aperte) dove la vegetazione può essere abbastanza fitta.
Qui mantenere il contatto visivo all’interno del branco è fondamentale per:
- restare uniti
- coordinare i movimenti durante la fuga dai predatori
C’è bisogno di un qualcosa che aiuti, in modo silenzioso, i vari membri del gruppo a vedere dove sono gli altri.
La “M” bianco-nera agisce come marker visivo, o appunto “follow me signal“: facilmente riconoscibile anche a distanza o tra l’erba alta, permette agli individui di seguire rapidamente i compagni, o i cuccioli la madre.

L'impala dal muso nero (Aepyceros melampus petersi)
Esiste una sottospecie chiamata Black-faced Impala, scientificamente Aepyceros melampus petersi, che si trova soprattutto in Namibia (parco Etosha) e in Angola.
È più grande e leggermente più scuro dell’Impala comune, ma soprattutto ha una distintiva macchia nera lungo il naso.
È più raro e considerato vulnerabile, a causa della limitata distribuzione geografica.
Struttura sociale
La società degli impala è complessa e dinamica.
I branchi di femmine (con i piccoli) possono essere molto numerosi, arrivando anche a 50 individui.
I maschi si riuniscono in gruppi (chiamati “bachelor’s groups“), ma durante la stagione riproduttiva (aprile – maggio) alcuni maschi adulti cambiano comportamento.
Stabiliscono e difendono un territorio, in modo strategico: se vicino a fonti d’acqua e buon cibo, il territorio è migliore, perché l’obiettivo è intercettare le femmine che ci passano.
Ok le femmine sono entrate nel territorio, e cosa succede?
Succede che il maschio fa di tutto per trattenerle e non farle più uscire.
Cerca di trattenerle fisicamente all’interno dei suoi confini.
Se queste non sono convinte le insegue, le blocca.
Vocalizza (emettendo suoni bassi e rauchi) per scoraggiarle dall’uscire.
Insomma, i maschi possono diventare dei gran rompicoglioni.
Ma le femmine hanno comunque dei momenti buoni per svignarsela.
Possono allontanarsi se il maschio è debole (magari è un giovane alle prime armi) o impegnato a controllare troppe femmine nel territorio.
E se il maschio è disturbato da altri sfidanti, è facile alla distrazione e può perdere alcune femmine.
Come si stabilisce la dominanza tra maschi di impala?
1. Prima fase: intimidazione e posture
Prima di combattere, i maschi cercano di evitare il conflitto fisico diretto, perché ogni ferita può essere pericolosa in natura.
L’obiettivo è impressionare e spaventare l’altro maschio senza dover arrivare al combattimento.
Si esibiscono entrambi in una parata di postura:
- gonfiano il corpo
- sollevano la testa e mostrano il profilo laterale
- emettono di vocalizzazioni profonde (praticamente ruttano)
- marciano lentamente davanti al rivale
E rutta.
2. Se nessuno si ritira: il combattimento fisico
Se nessuno dei due cede, si passa allo scontro vero e proprio:
- abbassano la testa e si incrociano le corna
- si spingono l’uno contro l’altro con grande forza
Le corna a forma di lira degli impala (no, non la nostra vecchia moneta, ignorante, la lira era uno strumento musicale a corde) sono progettate per assorbire l’urto e limitare i danni, proprio per evitare che le lotte siano letali.
3. Finalmente la dominanza
Alla fine il maschio più forte, quello che ha resistito di più nelle spinte, ottiene il diritto di possedere il territorio e quindi tentare di trattenere le femmine che ci passano.
Il maschio sconfitto si ritira spontaneamente, senza bisogno di essere inseguito o gravemente ferito.
Accoppiamento e corteggiamento
La stagione degli amori di solito coincide con la fine della stagione delle piogge (aprile – maggio).
Per questo periodo i maschi hanno già stabilito i loro territori tramite parate e lotte per la dominanza, e sono pronti ad accogliere le femmine nel loro regno.
Quando appunto arriva una femmina ricettiva, il nostro Casanova la cerca di impressionare con un corteggiamento che prevede:
- l’emissione di sensualissime vocalizzazioni che sono un misto tra un latrato e un rutto
- il sexy show in cui vengono mostrate le chiappe e la M bianconera
- e poi gli inseguimenti rituali della femmina
Cura dei piccoli
La strategia adottata dagli Impala per massimizzare la sopravvivenza dei piccoli, è quella di sfornarli tutti assieme.
Le femmine partoriscono infatti entro un breve periodo (di solito novembre – dicembre).
Così la savana di punto in bianco si riempie di tante piccole e facili prede. In questo modo i predatori vengono sovraccaricati: c’è molto più cibo di quanta ne sia la necessità.
In questo modo aumentano le probabilità di sopravvivenza per tanti piccoli.
Come succede in tantissime specie di ungulati, alla nascita il piccolo viene lasciato nell’erba alta o comunque ben nascosto dalla vegetazione. La madre torna più volte al giorno per l’allattamento, ma è fondamentale che il piccolo stia in silenzio e immobile, per non farsi trovare dai predatori.
Quando sarà pronto a seguire la madre e a correre, potrà unirsi al branco delle femmine.
Il padre non partecipa alle cure del piccolo.













